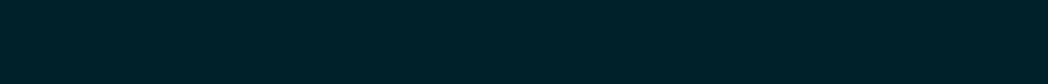Per nove stagioni, Gabriel Omar Batistuta fu molto più del terminale offensivo della Fiorentina: ne incarnò lo spirito, la passione, l’orgoglio. Non soltanto attraverso i numeri - 152 gol in 243 presenze ufficiali in Serie A, primato assoluto nella storia del club - ma soprattutto con l’attitudine di chi scelse l’appartenenza alla gloria facile, la fedeltà alla convenienza.
Con la maglia viola addosso, "Batigol" divenne un’icona, elevato al rango di semidio da una piazza che lo adottò come figlio e lo difese come bandiera. Firenze lo amò visceralmente, e lui rispose restando nei momenti più difficili, quando chiunque altro avrebbe salutato.
Nel 1993, con la Fiorentina retrocessa in Serie B, non abbandonò la nave. E anche quando le big bussarono alla porta, preferì restare. I tifosi lo adorarono, lui ricambiò con gol da ogni posizione, con esultanze col cuore in mano e quella chioma ribelle che sventolava tra i venti del Franchi. Non fu solo un centravanti: fu un simbolo, quasi una promessa d’eternità.
Ma il tempo, si sa, presenta sempre il conto. E nell’estate del 2000, a 31 anni, Batistuta prese la decisione più sofferta della sua carriera: lasciò Firenze per inseguire un sogno chiamato Scudetto, accettando l’offerta della Roma.
"Non dirò mai cosa mi ha dato fastidio della società. Voglio solo fare il calciatore. Con il club non condividevo molte cose. Ritengo giusto cambiare, per non soffrire più”, dichiarò con dignità e misura. A Trigoria trovò una squadra ambiziosa, guidata da un tecnico esigente come Fabio Capello e trascinata da un simbolo come Francesco Totti. Il pubblico romanista lo accolse con entusiasmo, quello viola trattenne le lacrime ma non gli voltò mai le spalle.
Il giorno del destino
26 novembre 2000, ottava giornata di campionato: Roma-Fiorentina. La prima da ex, la più attesa, la più temuta. L’Olimpico fu un catino carico di emozione e tensione. In campo, il match rimase bloccato: la Fiorentina, con Rui Costa capitano, si difese con ordine, Toldo fu in giornata di grazia. La Roma spinse, ma non sfondò.
Poi, l’83’. Una palla vagante al limite dell’area, colpita di testa da Gigou verso Batistuta. Il "Re Leone" non ci pensò. Destro secco e potente: il pallone s’insaccò, Toldo battuto. L’Olimpico esplose. Fu 1-0. La Roma volò, restò in vetta. Ma Batistuta no. Rimase immobile. Si coprì il volto con le mani. Pianse.
L’inquadratura strinse sul suo volto. Gli occhi lucidi, lo sguardo basso, il respiro affannato. Fu un momento di pura, struggente umanità. Quel gol non fu solo una rete decisiva. Fu uno squarcio emotivo, una frattura tra il passato e il presente, tra ciò che si era stati e ciò che si era chiamati a diventare. In quell’istante Batistuta non fu né romanista né ex viola: fu un uomo che segnò contro una parte di sé stesso.
Quel gol risultò decisivo nella corsa allo Scudetto giallorosso, l’unico della carriera di Batistuta. Ma nessuna fotografia di quella stagione ebbe la stessa forza iconica di quelle lacrime sotto il cielo di Roma. Più di un gol. Più di una vittoria. Un addio muto e lacerante a un amore mai davvero finito.